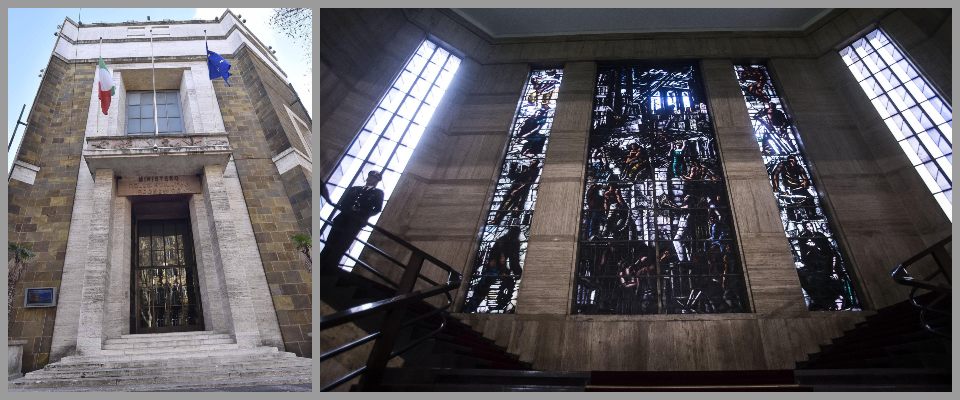Fuga volontaria dal lavoro: un fenomeno che sta arrivando anche in Europa, tra crisi morale e sociale
Abituati a fare i conti con le percentuali della disoccupazione e con le trasformazioni aziendali, strette tra globalizzazione e nuove tecnologie, non possono non inquietarci gli scenari della “Grande Dimissione” (Great Dismission), ultima frontiera sociale “made in Usa”, ormai arrivata anche in Europa. Di che si tratta ? In sintesi: con riferimento al novembre 2021 in America ben 4 milioni e mezzo di persone hanno deciso di lasciare il lavoro o di non tornarci dopo che le imprese le avevano richiamate in ufficio. Dall’inizio del 2021 – ci dicono le statistiche – quasi ogni mese viene battuto un nuovo record di dipendenti dimissionari. Prima del Covid erano poco più di 3,5 milioni al mese, a metà dell’anno hanno raggiunto quota 4 milioni, ora siamo oltre i 4 milioni e mezzo.
L’Europa, a pochi mesi di distanza, ha cominciato a seguire lo stesso trend. Il vacancy rate, ovvero il tasso di posti vacanti, è, infatti, ai massimi anche nell’Unione Europea, secondo gli ultimi dati di Eurostat. Nel terzo trimestre del 2021 le posizioni rimaste scoperte sono salite al 2,4%, appena sopra il massimo del 2,3% toccato nel primo del 2019, con picchi nei Paesi che storicamente hanno tassi di disoccupazione più bassi, come Repubblica Ceca (5,1%), Belgio (4,7%), Paesi Bassi (4,2%), Austria (3,8%), Germania (3,3%). Ad abbassare la media sono Spagna e Grecia, sotto l’1%, e l’Italia, che con il suo 1,8% raggiunge anch’essa un piccolo record.
Quali le cause ? Il Covid19 ci ha messo certamente lo zampino. L’esperienza della pandemia ha convinto molti a riconsiderare le proprie aspettative: c’è la rivalutazione del tempo libero e della famiglia, ma c’è anche il rifiuto di condizioni lavorative troppo pesanti in termini di ore e di organizzazione del lavoro. E poi, particolarmente negli Stati Uniti, c’è una mobilità lavorativa maggiore, specie da parte delle giovani generazioni, determinata anche da una forte domanda delle aziende in diversi settori “emergenti”.
Un’inchiesta di Ypulse sottolinea che nell’Europa Occidentale ben il 20% dei Millennials ha lasciato il proprio posto di lavoro nell’ultimo anno. E come in Usa anche nel Vecchio Continente tra le cause vi sono sia la ricerca di migliori opportunità e paghe più alte, sia una maggiore attenzione alla tutela della propria salute mentale e ad una diversa gestione dei tempi lavorativi.
Dietro queste “ragioni” la realtà appare però ben più inquietante, viste anche le avvisaglie che provengono da oltreoceano.
Secondo Nicholas Eberstadt, economista dell’American Enterprise Institute ed autore del libro Men Without Work, un vero e proprio esercito di dieci milioni di uomini abili si è “dimesso dal lavoro”. Alcune delle ragioni legate a questa “fuga” pare siano le “epidemie di oppioidi”, la cultura dei videogiochi e la crescente incapacità dei maschi adulti di fungere da “capofamiglia”. Invece di lavorare, molti uomini stanno semplicemente a casa senza fare niente. Un rapporto del governo statunitense rileva che i “dimissionati” passano davanti ad un video fino a duemila ore all’anno, quasi come un lavoro a tempo pieno. Film in streaming, videogiochi e social media riempiono le loro giornate. Con il risultato – scrive Eberstadt – che crisi “morale e sociale” vanno di pari passo.
Di fronte a questi “scenari” la questione si complica. E non tocca solo il mutare del “mercato del lavoro”, gli orientamenti dei lavoratori, le domande delle giovani generazioni, una diversa gestione dei tempi lavorativi. C’è naturalmente anche questo, ma – a ben guardare nel profondo del tessuto sociale ed economiche delle società contemporanee – ad emergere è una sorta di “precarizzazione” socio-culturale che tutto sembra relativizzare: i rapporti personali, la famiglia, la politica ed ora anche il lavoro, “ultima spiaggia” di un’appartenenza sociale, che andava ben oltre le ragioni economiche ed il mero sostentamento, diventando il centro di una visione del mondo e della vita, capace di estendere all’universo e proiettare nel cosmo l’attività delle officine.
Il lavoro – scriveva Ernst Jünger (L’Operaio, 1932) – non è un mezzo per acquisire vantaggi economici, ma l’espressione della vita: “Il lavoro non è, puramente e semplicemente, attività, ma l’espressione di un’essenza particolare che cerca di riempire il suo spazio, il suo tempo e di adempiere alle sue leggi”.
Dalla prima rivoluzione industriale, nella quale il lavoro veniva considerato come una merce, e, come merce, il suo prezzo veniva stabilito dal classico rapporto della domanda e dell’offerta, l’idea del lavoro non a caso è diventato, durante il XX Secolo, un diritto fondamentale ed insieme uno strumento d’integrazione sociale e di partecipazione.
Pensare, oggi, sull’onda della “Grande Dimissione”, di vedere travolta l’idea stessa di lavoro nel nome di un neo individualismo di massa, che si fa precarizzazione diffusa (e non solo a livello produttivo) significa perdere un fattore essenziale e fondante della nostra “ragion d’essere”. Da qui bisogna partire per una profonda opera di “ricostruzione”, insieme morale e sociale.
Ognuno deve fare la propria parte: la politica (attivando i necessari processi formativi e le doverose misure compensative); le aziende (impegnandosi a “fidelizzare” i lavoratori, attraverso adeguamenti salariali, politiche premianti ed organici processi partecipativi); il sindacato (per allargare le tutele, a cominciare dalle nuove figure professionali, ma senza dimenticarsi di quelle “tradizionali”); la cultura (per ricostruire l’identità sociale, attraverso i processi di intermediazione sociale e la costruzione di nuovi, più forti modelli identificativi). Il rischio – d’altro canto – è di “dimettersi” più che dal lavoro dalla vita, con tutto quello che ne consegue.