D’Annunzio e Pirandello cordialissimi nemici, ma c’è un filo letterario che li lega in modo indissolubile

Una lezione di letteratura ma anche un evento teatrale: così Angelo Piero Cappello è riuscito a catturare l’attenzione del pubblico martedì sera all’Auditorium di Roma, raccontando di D’Annunzio e di Pirandello e del loro essere “cordialissimi nemici”. Espressione che è anche il titolo del libro che Cappello ha di recente pubblicato (Ianieri edizioni). Una serata, quella di martedì, arricchita dalle letture di Anna Bonaiuto.
Perché cordialissimi nemici? Perché il giudizio che Pirandello dà di D’Annunzio è a tutto tondo negativo e si fonda sull’opposizione tra vita e scrittura. Per Pirandello o si vive o si scrive (espressione che usò durante una prolusione all’Università di Catania parlando di Giovanni Verga). O ci si concentra su una vita esuberante, sempre oltre il limite, o ci si immerge nella creazione artistica, quasi annullandosi. O si fa della propria vita un’opera d’arte inimitabile o si regala alla scrittura l’impronta del genio, sublimando nella scrittura la vocazione artistica. Celebrando ancora Giovanni Verga nel 1931 in un discorso all’Accademia reale d’Italia Pirandello contrappone l’arte autentica di Verga a quella di D’Annunzio che produceva un “abbaglio fascinoso” ma era prodotta da un uomo che creava una tal confusione “d’arte e di vita da non potersi dire quanto della sua arte sia nella sua vita, e quanta della sua vita nella sua arte: una tal confusione salvando nel solo modo con cui era possibile , cioè sotto il lussuoso paludamento d’una continua letteratura”.
D’Annunzio dal canto suo non si curò mai di quelle critiche, convinto com’era che a uno come lui fosse consentita la sintesi superiore tra il saper vivere e il saper scrivere nel segno di un’arte che fosse simbolo, esempio, visione del mondo. La scrittura era in lui un bisogno insopprimibile. “Scrivere è per me il bisogno di rivelarmi, il bisogno di risonare, non dissimile dal bisogno di respirare, di palpitare, di camminare incontro all’ignoto nelle vie della terra”.
D’Annunzio scrittore esteta, Pirandello scrittore umorista. Dove umorismo va inteso come appunto lo intendeva Pirandello nel suo saggio del 1908 e cioè come indirizzo che trasforma il romanzo in una osservazione di sé mentre si vive. Scrittura e vita, allora, sono destinate a intrecciarsi.
Il testo di Cappello è un testo di critica letteraria nel senso classico. Parte da una inimicizia dichiarata per mostrare una “scoperta”: i due nemici in realtà sono profondamente uniti dal loro desiderio di sperimentare, uscendo fuori dall’orizzonte in cui hanno mosso i primi passi, che è quello del verismo. E i due nemici, ci racconta Cappello, sono destinati fatalmente a incontrarsi. Un incontro tutto da rivelare, diverso da quello imposto da Benito Mussolini che chiese a Pirandello di mettere in scena La figlia di Iorio.
Nel suo testo Cappello infatti ci spiega come una pagina di D’Annunzio dal Vangelo secondo l’Avversario del 1924 divenga fonte d’ispirazione della pagina finale del romanzo pirandelliano Uno nessuno e centomila per il quale l’autore non riusciva a trovare un degno finale. Il linguaggio estatico e mistico del primo testo, quello di D’Annunzio, diventa il canovaccio utile a Pirandello per descrivere l’insorgere della follia nel protagonista del suo romanzo. Non possiamo certo sapere quale fosse il grado di consapevolezza di questa trasfusione da pagina a pagina ma è certo che Pirandello leggeva D’Annunzio con attenzione, pur criticandolo.
Un’ultima osservazione sui due cordialissimi nemici: essi furono diversi anche nei confronti della morte. Morte da poeta soldato quella di D’Annunzio, inumato con un po’ di terra del Carso, accompagnato in chiesa in un turbinìo di bandiere e gagliardetti mentre i cronisti annotavano solerti come si collocavano le sue innumerevoli donne nel corteo funebre. Una cerimonia mondana.
Pirandello, che come tutti i siciliani era dominato dal pensiero della morte, lasciò scritte disposizioni francescane: “Morto non mi si vesta, mi s’avvolga nudo in un lenzuolo. Bruciatemi e il mio corpo appena arso sia lasciato disperdere…”. Non andò così, come viene narrato in un bel libro di Roberto Alajmo che si intitola Le ceneri di Pirandello. Ceneri che alla fine si scoprì, grazie all’esame del dna, che non erano neanche le sue o meglio che solo in parte erano le sue. Vita, scrittura, morte. Diversi anche nella morte D’Annunzio e Pirandello. Il rito per il primo, il mistero per il secondo ma in alcune pagine, quelle che Cappello ha scoperto, i loro destini si sono fusi, aggregati, mostrandoci che la diversità è sempre ricchezza.
ARTICOLI CORRELATI
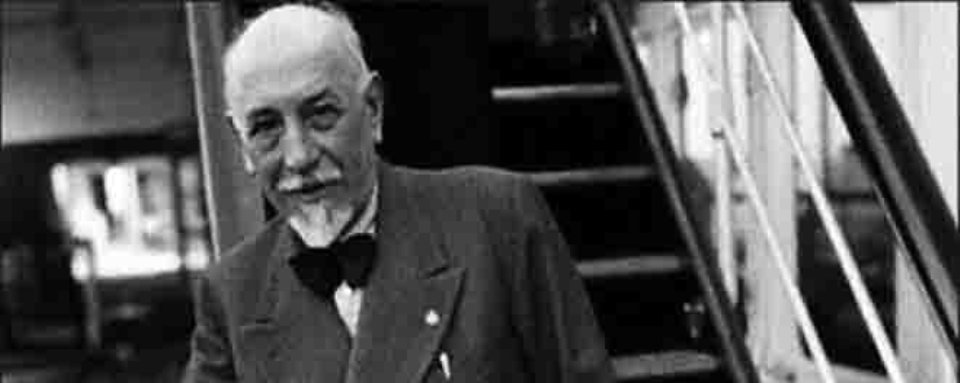
E' l'anno di Pirandello. In un libro la storia d'amore tra il Maestro e Marta Abba

