
Dopo 103 anni…
Liberare la storiografia dalla politica per liberarsi dei nostalgici: studiare serve anche ad andare oltre
La storia viene piegata a una continua campagna elettorale, ma sarebbe ora di raccontare le cose per come sono andate. Prendendo atto che tanto nessuno nel 2025 vota a destra per nostalgia del 1925 e nessuno vota a sinistra per vendicarsi del 1925
Sono trascorsi, pochi giorni fa, 103 anni dalla Marcia su Roma. Ci vorrebbe un libro (l’ho scritto, nel vuoto), e facciamo invece un piccolo sunto: Luigi Facta, presidente del Consiglio di uno dei tanti governicchi, propose lo stato d’assedio contro le squadre fasciste; il re Vittorio Emanuele III non lo firmò, e diede l’incarico a Mussolini; dopo di che Facta a Mussolini votò la fiducia, assieme a Giolitti e Croce per dire dei liberali, e ai Popolari (Gronchi fu sottosegretario), insomma tutti tranne la sinistra. Mussolini ebbe una maggioranza solidissima, e la utilizzò emanando una raffica di Regi Decreti, alcuni dei quali sono ancora in vigore, come quelli Gentile per la scuola, eccetera. Quanto al consenso, lo ha documentato De Felice quanto fosse quasi totalitario.
Sappiamo però che non era proprio del tutto vero. Diciamo che un terzo degli italiani erano fascisti; un terzo, governativi; un altro terzo o rassegnati o decisamente oppositori: tra questi, non pochi fascisti troppo fascisti. Sappiamo anche che il Ventennio non fu del tutto la perfezione della politica e dell’amministrazione. I nostalgici, che furono tantissimi dopo il 1945 e qualcuno c’è ancora, farebbero il lunghissimo elenco delle “cose buone”: riforme, provvidenze sociali, strade, ferrovie, bonifiche, città fondate, salute pubblica, scuola… e altre “cose buone” secondo la mentalità di tutto il mondo in quegli anni: dura repressione della criminalità e mafia, conquiste coloniali e di Fiume e Rodi…
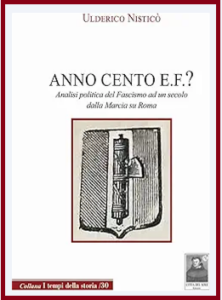 Il fascismo eliminò la democrazia? A parte che nel 1922 non c’era in giro tutta la democrazia che si millanta, se nel 1861 votarono effettualmente 200.000 persone, e per il suffragio universale, solo maschile, bisognò attendere il 1913; e il concetto di democrazia è uno dei più indefiniti fin da quando la praticavano, con dubbi risultati, ad Atene e in qualche altro luogo. È vero però che, dopo il 1925, vennero eliminati i partiti antifascisti (se li pianga chi vuole), ma poi dilagò il mussolinismo, e anche il partito fascista (Pnf) fu ridotto a un ente statale che faceva a sua volta tantissime “cose buone”… tranne la politica; e per vederla risuscitare ci vollero l’armistizio badogliano e la Rsi.
Il fascismo eliminò la democrazia? A parte che nel 1922 non c’era in giro tutta la democrazia che si millanta, se nel 1861 votarono effettualmente 200.000 persone, e per il suffragio universale, solo maschile, bisognò attendere il 1913; e il concetto di democrazia è uno dei più indefiniti fin da quando la praticavano, con dubbi risultati, ad Atene e in qualche altro luogo. È vero però che, dopo il 1925, vennero eliminati i partiti antifascisti (se li pianga chi vuole), ma poi dilagò il mussolinismo, e anche il partito fascista (Pnf) fu ridotto a un ente statale che faceva a sua volta tantissime “cose buone”… tranne la politica; e per vederla risuscitare ci vollero l’armistizio badogliano e la Rsi.
I fatti provarono anche che l’Italia fascista non aveva tutta la potenza militare che vantava e che molti altri le attribuivano, dopo l’Etiopia e la Spagna. Si trovava, quanto a debolezze di armamenti e organizzazione, nella stessa precaria situazione della Francia; anzi in verità, stava meglio; ma non fu all’altezza di Germania, Giappone, Usa, Gran Bretagna, Urss. Furono effetto di ciò il crollo militare del 1943, e il collasso politico del 25 luglio.
Ecco un modestissimo e rapidissimo esempio di come, dopo 103 anni, si potrebbe raccontare la storia d’Italia “sine ira et studio, quorum causas procul habeo”, senza faziosità, proprio perché chi scrive nel 2025 è lontanissimo dal 1925 e dallo stesso 1945… e anche dal 1946, dal 1968, dal 1994, tutte date del neofascismo e della sua fine. Il 2022, è un’altra faccenda. Non è solo che dice di essere un’altra faccenda: lo è sul serio, e per ragioni oggettive, e, non scarso motivo, di età. E lo è per due ragioni: la prima, che il mondo è profondamente cambiato dal 1922; e che siamo rimasti in pochissimi ad aver ricevuto una certa eredità, mentre sono morti quelli che potrebbero personalmente ricordare.
È successo molte volte. Quando morì Augusto, erano passati 58 anni dall’uccisione del prozio Cesare: 58 anni. Per l’epoca due intere generazioni attive, e Cesare e Cicerone si studiavano a scuola: una situazione, la scuola, che non favorisce la passionalità. Quando nel 1852 un Bonaparte si proclamò Napoleone III, erano passati anni 38 dalla caduta di Napoleone I. C’erano, in entrambi i casi, nostalgici di Cincinnato e di Austerlitz, ma era pura letteratura. A proposito: anche Napoleone I venne ripetutamente sconfitto a Mosca, a Lipsia, a Waterloo; e il nipote in Messico e a Sedan. Solo che gli storici francesi raccontano Waterloo come fosse un pareggio fuori casa invece di quella che fu, una scoppola definitiva. Gli storici italiani invece raccontano della Prima guerra mondiale solo Caporetto, e della Seconda l’8 settembre.
E invece sarebbe ora di sdoganare la storiografia dalla politica, anzi, peggio, dalla continua campagna elettorale che aduggia l’Italia ogni volta che va eletto non il governo ma un sindaco di paesello. E lo si può fare quasi senza rischio, tanto nessuno nel 2025 vota a destra per nostalgia del 1925; e nessuno vota a sinistra per vendicarsi del 1925. Lasciatemi lamentare che il problema non è cosa pensi un ventenne del 1925 della Guerra d’Etiopia 1935-6, ma il tragico problema è che tantissimi ventenni non sanno manco dove si trova l’Etiopia! È triste ma è così; e temo lo stesso per il Don e la Palestina. E anche lodare le bonifiche delle paludi presupporrebbe che la gente sappia cos’è una palude, e come fosse mortale abitarvi vicino.
A sinistra, del resto, ripetono le stesse invettive del 1830 sui “padroni”, ignorando che ormai è tutto denaro anonimo e multinazionale… e interclassista, e probabilmente l’operaio, con il suo librettino di risparmio, finanzia la società anonima sua “padrona”, e i soldi sono elettronici; e invece sono convinti, a sinistra e non solo, che il denaro stia nei forzieri del castello sotto sorveglianza di bruti sgherri. Ci sono dunque nostalgici del 1830 come ancora c’è qualche nostalgico del 1925.
Per completare il quadro, ci sono anche, con Rousseau, i nostalgici della Natura buona e pulita, abitata dal “buon sauvage” mite pacifico felice democratico; e che nemmeno se lo vanno a cercare nella isole della Polinesia, bensì pensano di vederlo in ogni reale o presunta emarginazione economica, e soprattutto umana, nelle periferie delle città. Insomma, ci sono in giro troppi nostalgici di qualsiasi nostalgia, e pure quelli della Prima repubblica; e pochi capaci di vivere nel 2025 ormai quasi 2026. Non si sono, signori del loro secolo, Federico II e Francesco d’Assisi e Domenico. Bisogna vivere nel XXI secolo, e studiare e raccontare la storia del passato; e studiare la storia insegna… a dimenticarla! Scrivere libri? Ma sì, se li legge qualcuno. Ci vorrebbero, se mai, dei bei film. Ne sogno due: uno sul 1943-5… e un altro, già che ci troviamo, sul 1860.

