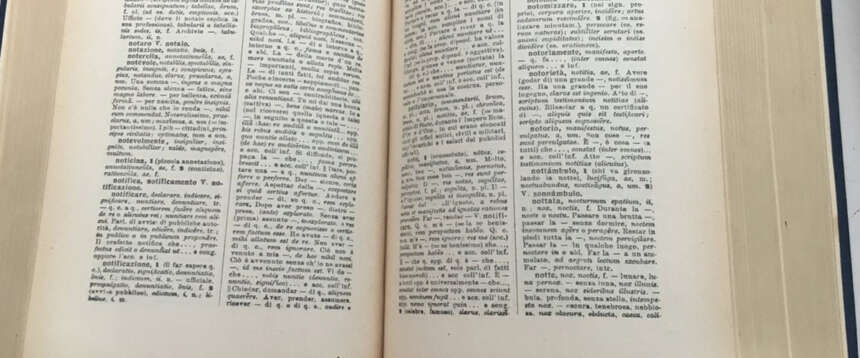
Come cambia la società
Anche la Francia sta scoprendo che la difesa della lingua è importante: “C’è una devicilizzazione in atto”. E in Italia?
Da oltralpe, attraverso la rivista “Éléments”, ci arriva l’invito a sottoscrivere una petizione in difesa della lingua francese. La denuncia è ben motivata. Essa – scrivono gli autori della petizione – si inquadra nel processo di “decivilizzazione in atto”: “Le cause sono ampiamente conosciute, come la decostruzione della famiglia e dell’autorità, e devono essere affrontate con decisione. Esiste però un fattore sottostante alla decivilizzazione che influenza tutti gli altri: la perdita del controllo del linguaggio”.
Il quadro offerto è disarmante. Gli insegnanti sono unanimi: la padronanza del francese tra i 15-25 anni è sempre più debole. Si tratta di ortografia, naturalmente, ma anche di sintassi, di vocabolario, di uso dei tempi e più in generale di difficoltà a comprendere e sintetizzare i testi e ad articolare le idee. In un liceo della Franca Contea, un insegnante constata che, nel primo anno dei corsi, solo due terzi degli studenti sono a loro agio con la lingua. Da qui l’invito: “E’ urgente difendere la lingua francese. E, prima di tutto, fermare il massacro del suo apprendimento”. Il fine: rimettere il francese in primo piano, per ridare il gusto della lettura, dell’ortografia, della parola giusta, della “bella parola”, invitando – attraverso la petizione – insegnanti, editori, giornalisti o uomini politici, a fare tutto il possibile per salvaguardare la lingua francese e soprattutto il suo apprendimento.
E l’Italia ? Noi non stiamo meglio della vicina Francia. In Italia una persona su tre non è più in grado di leggere un libro o un testo lungo. A denunciarlo il recente Report OCSE 2025 “Uno sguardo sull’educazione” che da un lato conferma una tendenza già in atto da anni, dall’altro testimonia il rischio di un analfabetismo di ritorno.
In un mondo dominato dalla digitalizzazione, in cui la maggior parte delle interazioni avviene attraverso gli schermi dei dispositivi e delle piattaforme social, la capacità di leggere, comprendere e mantenere l’attenzione su testi articolati o semplicemente più lunghi sta via via sempre più scomparendo. Tutto ciò comporta che una notevole parte della popolazione italiana stia lentamente perdendo l’alfabetizzazione funzionale, ovvero quella capacità di saper utilizzare le proprie competenze linguistiche per orientarsi nella complessità del mondo contemporaneo. La mancanza della lettura affievolisce la capacità di distinguere tra il vero e il falso, tra l’informazione e la manipolazione. Il formato dominante è ormai quello breve e superficiale; esempi ne sono lo status, il post, il titolo clickbait, il reel, il video breve da 15 secondi. Il risultato è che oggi sempre più persone, sia giovani che adulti, confessano di non riuscire a leggere più di una o due pagine senza distrarsi.
C’è poi l’uso eccessivo degli anglicismi. Troppo spesso termini che potrebbero essere chiari nella nostra lingua, sono sistematicamente sostituiti con parole inglesi, soprattutto in ambito politico, nelle amministrazioni pubbliche, nelle comunicazioni delle imprese e sulla carta stampata. Da “form” (modulo) a “market share” (quota di mercato), da “fashion” (moda), a “step” (per indicare le tappe di una programmazione), da “mission” (compito o missione) fino alla “stepchild adoption” (adozioni del figliastro) e a “recovery plan” (piano di recupero) è un proliferare di anglicismi, troppe volte immotivati, a cui sarebbe opportuno porre un freno.
Tutto ciò che richiede tempo, concentrazione e riflessione viene evitato; e questo ha un prezzo altissimo, non solo di tipo culturale ma anche sociale ed economico. Per non parlare dell’ennesimo paradosso di una Costituzione che sul tema della lingua appare a dire poco distratta. In sede di dibattito alla Costituente l’argomento venne appena sfiorato. A sollevare il problema della lingua, nel luglio del 1947, furono gli onorevoli Emilio Lussu e Tristano Codignola, preoccupati per la tutela delle minoranze (sancita dall’ articolo 6), che è peraltro esplicitata dall’articolo 3, dove si istituisce il principio di uguaglianza ed è affermato il divieto di discriminazione linguistica.
In breve: gli articoli 3 e 6, parlando di uguaglianza e tutela delle minoranze, sottintendono il fatto che esista una “maggioranza linguistica”, anche se nella Costituzione la lingua italiana non viene citata. Una ventina di anni fa, su richiesta della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati, è stata interpellata la stessa Accademia della Crusca. Gli accademici proposero di inserire la formula: “L’italiano è la lingua ufficiale della Repubblica Italiana” nell’articolo 12 della Costituzione, che parla di simboli come la bandiera. Ma non se ne fece niente, lasciando ancora l’Italia “sguarnita” rispetto agli altri Paesi. In Europa la maggior parte delle costituzioni ha infatti indicazioni riguardanti l’ufficialità della lingua.
Di legislatura in legislatura non sono mancate peraltro proposte riguardanti lo status e l’uso della nostra lingua. Purtroppo però oltre i buoni propositi non si è andati, forse perché è mancata quella “spinta” comunicativa in grado di portare il tema all’attenzione della più vasta opinione pubblica, sollecitando i necessari riscontri emozionali e spirituali, insieme ad altri richiami identitari. Un po’ come stanno provando a fare gli amici di “Éléments”, preoccupati della “perdita del controllo del linguaggio” e del conseguente processo di decivilizzazione.
La battaglia – cerchiamo di essersene consapevoli – va ben oltre la difesa della lingua. Essa ha una ricaduta immediata sull’appartenenza a una determinata comunità, sulla formazione dei cittadini e la comunicazione, perfino sugli scenari europei ed internazionali. La lingua è insieme passato, presente e futuro, declinati simultaneamente e quotidianamente. Comprenderne l’importanza vuole dire valorizzare un patrimonio inestimabile di bellezza e di sapienza, e dunque “ritrovarci”, come venne evidenziato nel Risorgimento, a partire dalla capacità seduttiva della nostra lingua. In fondo l’italiano è il quarto idioma più studiato al mondo, al punto da essere stato definito da Thomas Mann “la lingua degli angeli”. Non dimentichiamolo. Ed operiamo di conseguenza.

