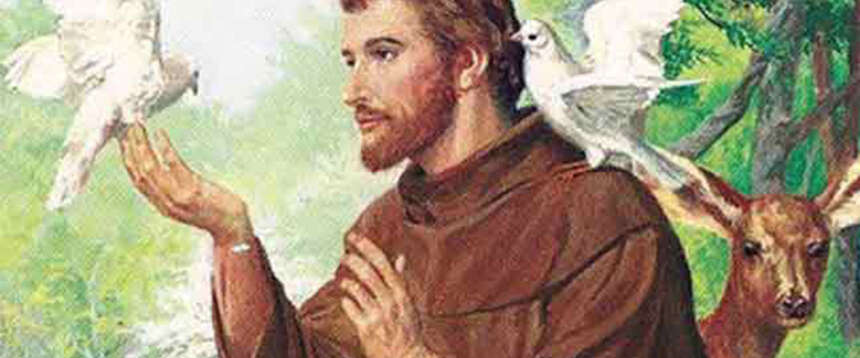
Tra fede e politica
San Francesco, festa nazionale: una bella iniziativa del centrodestra. Nel libro di Cardini l’idea del sacro unificante
Il 4 ottobre del 2026 tornerà a essere la festa nazionale di San Francesco? È un’ipotesi che si sta concretizzando, alla luce di una proposta avanzata lo scorso anno, ad Assisi, dal poeta Davide Rondoni, presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte del Santo, e fatta propria dal Governo Meloni, attraverso l’iniziativa parlamentare di Maurizio Lupi (Noi moderati) e Lorenzo Malagola (Fratelli d’Italia). La Camera ha dato il suo assenso e a breve ci sarà la valutazione del Senato.
In questo contesto ha un valore tutto particolare la riedizione aggiornata de I giorni del Sacro. I riti e le feste del calendario dall’antichità a oggi di Franco Cardini, saggio che vide la sua prima uscita nel 1983 (con Editoriale Nuova) per poi essere pubblicato dalle Edizioni il Cerchio ed oggi da Utet.
Con questa opera Cardini ci riconsegna il valore profondo delle feste, insidiate dall’organizzazione burocratico-produttivistica della società moderna e dalla nuova ripartizione delle frazioni di tempo libero: week-end, ferie e vacanze. Altra cosa evidentemente rispetto alla storia affascinante, antica e complessa, delle feste delle civiltà del Mediterraneo, e in particolare quelle dell’Occidente, le quali sono nate dalla trasfigurazione di culti antichi e di antichi rituali, che congiungevano, e ancora congiungono, la sfera religiosa con quella sociale: dai culti della fertilità alla scansione stagionale dei raccolti il sacro si trasfigura nel quotidiano e il quotidiano nel sacro.
Da qui la possibilità di ritrovare, attraverso la festa, il senso più vero di ciò che radicamento, tradizione, storia, folklore hanno espresso lungo i secoli ed ancora esprimono, in termini di aspirazione alla felicità, di ricerca sincera dell’identità, attraverso i desideri e le passioni, gli istinti e la fede, la nostalgia per il passato e l’ansia per il futuro.
In questa prospettiva la festa, intesa come una dimensione della vita associata, presente un po’ in ogni epoca ed in ogni cultura, viene a rispecchiare tale aspirazione alla felicità, ben aldilà di ogni determinismo temporale e geografico.
Che cosa unisce i culti misterici, le religioni esotiche come il mitraismo, al paganesimo dell’antica Roma, e poi al Cristianesimo? Quale linea rossa congiunge le forme della lecita follia carnevalesca dei tempi antichi con il Carnevale cristiano, che preannuncia ed esorcizza il magro tempo della Quaresima? Ed ancora: quanto sono diverse le nostre feste da quelle delle altre religioni rivelate, come l’Islam e l’Ebraismo?
Senza precludersi una necessaria analisi del significato generale della festa, Cardini ne affronta le diverse dimensioni (rito, gioco, liberazione, violenza) nel concreto delle esperienze locali. E tra analisi storica, antropologia culturale, tradizione, folklore, è il fascino sottile di verità antiche, eppure vive e vissute, a segnare I giorni del Sacro.
In un suggestivo sovrapporsi di culture, credenze e miti, la festa svela i suoi significati reconditi: diventa gioco e rito; elemento reintegratore ed insieme rinnovatore per la società, “libera la violenza ma fa sì che la sua energia venga costretta a scorrere in argini ben delimitati, leimpedisce di dilagare”; è momento di instabilità, di ritorno al caos e di risurrezione; è tempo sacro e tempo di dissacrazione civile.
Puntualmente Cardini verifica tali e tanti significati nel concreto delle esperienze, storicizzandone l’analisi e distinguendone gli elementi d’origine e la loro stratificazione. Non si può infatti fare risalire tutte le feste alla “notte dei tempi”, collegandole meccanicisticamente ai cicli della natura. In realtà – nota Cardini – un ciclo festivo è un palinsesto nel quale sono compresenti elementi d’origine molto diversa, sia dal punto di vista cronologico che da quello religioso, mitologico o politico in senso ampio. Tale lettura è a maggiore ragione necessaria se ci si pone il problema, fondamentale per la cultura europea, del rapporto tra le grandi feste liturgiche della Cristianità ed i riti della tradizione pagana.
Se eredità vi è stata, come vi è stata, il problema – secondo l’autore de I giorni del Sacro – non è quello delle eredità delle forme bensì quello del mutamento dei contenuti e quindi dei referenti culturali. Ciò è concretamente verificabile, a cominciare perfino dalla tradizione del Natale, dei miti di morte e resurrezione, già propri di Dioniso, di Attis, di Adone, di Osiride, fino ad investire grandi e piccoli avvenimenti festivi, dal Carnevale alla Quaresima, alle feste locali.
Ben oltre le complesse ragioni storico-folkloristiche, che innervano le diverse feste, è l’identità comunitaria ad emergere e a farsi con la festa esempio vivente di ciò che Ferdinand Tönnies definiva “volontà organica”, cultura viva delle comunità, urbane o rurali, in cui l’appartenenza ad una contrada, ad una corporazione professionale, ad una confraternita, diventa l’occasione non per lo scontro dissolutore, ma per la ritualizzazione e la catarsi, nella festa che si fa sfida, disputa “a maggior gloria della comunità cittadina, del suo Santo patrono”, mentre la rivalità si stempera in una superiore concordia, in un’identità rinnovata.
Quanto ciò, oggi, ancora resista nelle pur persistenti tradizioni popolari e nel recupero che di talune feste è stato positivamente compiuto, è difficile e complesso verificare. Certo è che, parlando della festa nel suo profondo significato, non si può prescindere da una realtà “organica” rispetto alla società che la esprime e che, sotto la spinta di una modernizzazione forzata e sradicata, è evidentemente mutata nel profondo.
Ciò tuttavia – è anche la tesi di Cardini – non significa rassegnazione ed accettazione acritica della realtà. E’ – al contrario – anche grazie alla riscoperta consapevole del tempo festivo che si può risacralizzare l’esistenza dei singoli e delle esistenze. In questa prospettiva la festa può diventare un modello plausibile di riferimento e capirla, capirne il valore – come invita a fare I giorni del Sacro- una indicazione spiritualmente vitale per la “ricostruzione” dell’uomo e delle comunità, un vero e proprio progetto di integrazione sociale e culturale per ritrovare il senso di appartenenze dimenticate.

